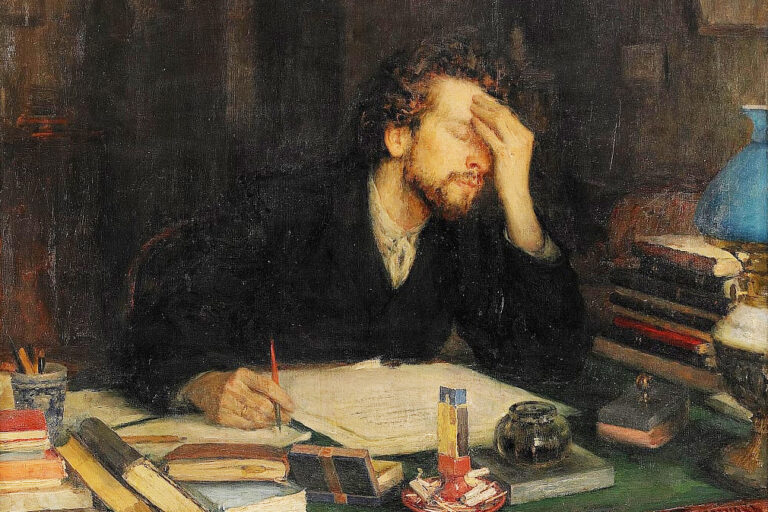“Le città sono un insieme di tante cose: di memoria, di desideri, di segni d’un linguaggio; le città sono luoghi di scambio, come spiegano tutti i libri di storia dell’economia, ma questi scambi non sono soltanto scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri, di ricordi”[1] (I. Calvino) La percezione dello spazio che viviamo è la somma di stimoli che accumuliamo nel tempo attraverso una serie di azioni quotidiane che ci portano a considerare le distanze e i luoghi in una particolare maniera; processo che avviene non solo attraverso l’uso che ne facciamo, ma anche in relazione al loro valore posizionale, al significato simbolico, alla loro accessibilità o meno, alla densità e al passaggio delle persone che li abitano. Persino in funzione delle loro dimensioni, o ad altre caratteristiche prettamente estetiche, possiamo mutare il nostro atteggiamento verso lo spazio nel quale ci muoviamo. Ma mentre lo spazio interno (un abitazione, l’ufficio, un teatro) risponde quasi sempre a logiche di tipo funzionale anche perchè più facilmente modellabile e passibile di trasformazioni anche rapide e soggettive; lo spazio esterno è sempre uno stratificarsi di sensazioni che perdurano da secoli ed è soggetto a cambiamenti naturali (spesso lenti) coerenti con la propria identità. Tuttavia gli uomini interpretano lo spazio urbano leggendo i cambiamenti sociali, d’uso e funzionali, accellerando i suoi processi di trasformazione, operando quindi, con una logica dettata dalla conoscenza, scelte di tipo urbanistico. L’uomo (l’urbanista) è, in questo caso, la benzina che alimenta la macchina della storia. Questa ottica di lettura dello spazio urbano è la chiave del pensiero teorico di Aldo Rossi magistralmente esposto in “L’architettura della città”, così riassunto da Paolo Portoghesi “(Aldo Rossi) …partiva dalle città considerandola un bene che si accumula gradualmente, in cui le esperienze dell’uomo si aggiungono l’una all’altra, creando qualcosa che non acquista significato solo in base all’aspetto che ha assunto nella fase più vicina a noi, ma che continua a significare, proprio attraverso la sovrapposizione e la sintesi delle esperienze succedutesi nella storia”[2]. L’interpretazione dello spazio urbano e del suo carattere sono fenomeni che vanno inquadrati in una visione democratica e, per certi versi, illuminista, della storia. Le grandi trasformazioni urbanistiche che hanno cambiato, o provato a cambiare, il modello tipologico di una città, hanno avuto successo solo se sono state accompagnate dal previsto (e auspicato) riconoscimento sociale, estetico, morale dei cittadini. Riconoscimento che può avvenire nel corso dei decenni come può non avvenire mai. La fondazione delle città greche, tramite il tracciato Ippodameo dei cardi e dei decumani e l’agorà al centro, ubbidiva ad una ragionevole logica di organizzazione e controllo sia pratico e sociale che prospettico della forma urbana e dei suoi abitanti. Prova ne è che molte città contemporanee conservano con attenzione il loro ortogonale tracciato storico e i suoi slarghi (Napoli, Verona, Aosta ecc.). Il piano di Sisto V, realizzato da Domenico Fontana, per la Roma del ‘500 era una coraggiosa operazione di rilettura policentrica del centro storico in sintonia con la percezione dello spazio, rinnovata dalla sensibilità della coscienza barocca. L’apposizione delle colonne rispondeva ad esigenze di visibilità in slarghi già parte integrante di quella zona della città. Gli sventramenti del XIX secolo (la Parigi di Hausmann, la Napoli del risanamento) rispondevano a quella imprescindibile esigenza di regolare, sia per motivi sanitari che di ordine pubblico, un tracciato viario confuso, privo di direzioni chiare e di spazi di aggregazione. Operazioni più recenti come quella dell’EUR nella capitale, rimangono in bilico tra il giudizio della storia e l’attuale interpretazione degli utenti reali. La costruzione dei quartieri “dormitorio”, specie dopo la legge 167/62, ha, viceversa, pagato il prezzo della scarsa conoscenza. L’esperimento della città “orizzontale” (quartiere Zen a Palermo, il Corviale a Roma) e la pianificazione figlia di agevolazioni giurisprudenziali (Scampia a Napoli) sono chiari esempi di cattiva lettura dello spazio urbano, della negazione dell’identità sia fisica che sociale di una città. Al di là della perizia delle opere, della technè impiegata e del valore estetico dei singoli “pezzi”, sono stati gli uomini, ancor prima della storia, a bocciare senza appello questi esperimenti. Sono questi, alcuni esempi noti di trasformazioni urbanistiche (opera dell’uomo), che hanno legato gli elementi funzionali alla natura del territorio, acquisendo con il passare del tempo quel valore simbolico che è proprio della città. La nascita della disciplina urbanistica è difatti strettamente legata ad una visione positivistica dell’intervento umano, ancora attuale è la definizione che ne diede Giovanni Astengo: “L’urbanistica è la scienza che studia i fenomeni urbani in tutti gli aspetti per intervenire nel territorio per costruire, organizzare, modificare e collegare città e ambiente”[3]. L’urbanistica, in sintesi, pur riguardando l’architettura non la comprende direttamente. Gli architetti si assumono la responsabilità di dare forma ad una città, attraverso un attento lavoro che comprende più discipline e limitando al massimo scelte di gusto, soggettive e autoreferenziali. Sottraendo quindi (al lavoro dell’urbanista) l’elemento di arbitrarietà che appartiene, anche se con gli opportuni distinguo, all’architettura, e che è parte integrante dell’arte in quanto tale. Questo (auspicato) dialogo costante tra città ed architetto, città e abitanti, che si traduce nelle scelte di pianificazione che ne mutano la forma è efficacemente riassunto da L.Quaroni “…l’architetto porta alla costruzione della città la sua qualità: il disegno. (…) Porta un metodo di lavoro, una tecnica di progettazione, di comunicazione delle idee. Ma tutte queste qualità interne non potrebbero esistere se non ci fosse qualche realtà esterna alla quale esse sono dedicate. (…) quella (la realtà) di tutti i cittadini, quelle che all’architetto chiedono la città, e sono la committenza. C’è dunque un dialogo continuo fra l’architetto, gli amministratori e i politici (…)”[4]. Quando questo tipo di dialogo viene a mancare, quando la città sociale, vaporizzandosi, diventa entità astratta, assistiamo a quelle storture incomprensibili che i cittadini non comprendono o che, talvolta, giudicano di cattivo gusto. L’imposizione di tracciati viari, di brani di città, di piazze, di interi quartieri, arredi urbani o monumenti, è un operazione demiurgica se operata al buio, folle se è il risultato di logiche di mercato, clientelari, affine a scelte estetiche di dubbio gusto, se è un artificio virtuale e non virtuoso, formale e non di contenuto. All’interno di questa logica, operando un salto di scala, è indispensabile capire quali sono gli elementi fisici che praticamente condizionano la forma della citttà. Tra questi, senza dubbio, sempre seguendo la definizione di Aldo Rossi, vanno considerati gli “elementi primari”, categoria che comprende i cosiddetti “monumenti”. (1. continua…) —————————————————–
[1] I. CALVINO, (Presentazione de) “Le città invisibili” , Torino 1972 [2] P. PORTOGHESI, “I grandi architetti del novecento”, Roma 1998 [3] G. ASTENGO, “Enciclopedia Universale dell’arte”, Firenze 1987 [4] L. QUARONI, “La Torre di Babele”, Padova 1967
La memoria delle città (parte prima)
(Visited 121 times, 1 visits today)